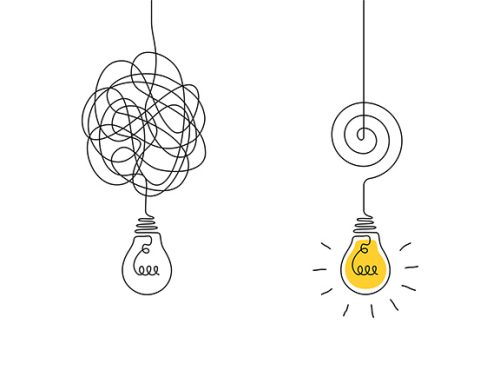di Massimo Cozza*
La pratica quotidiana nei Dipartimenti di Salute Mentale sta diventando sempre più difficile, non solo per la carenza di risorse, così come ben evidenziato nelle analisi della SIEP sulla base dei dati rilevati dal Ministero della Salute, ma anche per le nuove responsabilità che si tendono ad affidare ai servizi pubblici.
Da un lato pervengono ai Servizi richieste di intervento per problematiche che potremmo definire sia sociali, dal barbonismo agli anziani soli, sia antisociali, dalle liti/aggressioni più svariate alla microcriminalità. Dall’altro, vengono sempre più spesso imputati agli psichiatri, e ormai anche agli altri operatori della salute mentale, gli atti auto ed eterolesivi compiuti dagli utenti in carico.
Contemporaneamente dobbiamo, e vogliamo, portare avanti la nostra mission di tutela della salute mentale, a partire dalla priorità dei percorsi di cura per i disturbi schizofrenici, dell’umore e gravi di personalità, come indicato dalla Conferenza delle Regioni.
Chi ha vissuto la stagione della riforma della 180, con la chiusura dei manicomi, non avrebbe mai immaginato che, quaranta anni dopo, sarebbero state attribuite al centro di salute mentale le responsabilità per i crimini eventualmente compiuti da un utente in carico al di fuori dell’ambiente sanitario.
Così come, sull’onda dell’aumento delle azioni legali per i casi di vera e presunta malasanità, con forti interessi che ruotano intorno alle richieste di risarcimento, si tende sempre più a cercare la responsabilità psichiatrica nei gesti suicidari, ben oltre le evidenze scientifiche.
Se questo avviene, una parte della spiegazione risiede anche nel senso di onnipotenza che a volte pervade gli psichiatri, inducendo a credere che con un certo trattamento farmacologico, o con ricoveri più o meno lunghi, vi sia la certezza di evitare un suicidio o un comportamento delittuoso. Troppo spesso, infatti, in ambito clinico e forense, si confondono i fattori di rischio con i determinanti certi. Partendo da uno o più fattori di rischio pre-esistenti, aspecifici, si pretende di stabilire un nesso causale, non dimostrabile scientificamente, con un atto auto o eterolesivo in una specifica persona, con una biografia unica.
Forse sarebbe opportuno rileggere l’articolo di Joseph C. Franklin e colleghi: “Risk Factors for Suicidal Thoughts and Behaviors: A Meta-Analysis of 50 Years of Research” (Psychological Bulletin Vol. 143, No. 2, 187 – 232, 2017). Si apprenderebbe che, analizzando 50 anni di pubblicazioni scientifiche in materia, si individuano oltre i disturbi psichiatrici una molteplicità di fattori di rischio per il suicidio, a partire dall’ambiente sociale ed economico. Analogamente, la nota informativa ISTAT del 15 febbraio 2017, “Malattie fisiche e mentali associate al suicidio: un’analisi sulle cause multiple di morte”, evidenzia che nei certificati di decesso dei suicidi riferiti al triennio 2011 – 2013 solo nel 15,1 % c’è una menzione di malattia mentale.
Questo, ovviamente, non esime gli psichiatri dal mettere in atto i possibili trattamenti preventivi e le possibili cautele, con perizia, diligenza e prudenza, considerando la storia di ciascuna persona.
In questo quadro va riaffermato che la posizione di garanzia si pone in primo luogo come responsabilità di cura e di tutela della salute mentale, senza trasformarla in psichiatria difensiva e senza cedere a chi vorrebbe riaffidare alla psichiatria compiti impropri di controllo sociale in una logica neomanicomiale.
È giunto anche il momento che gli psichiatri, gli operatori della salute mentale ed in primo luogo le società scientifiche riaffermino il primato della complessità in salute mentale rispetto ad una logica semplicistica e riduzionista, sia in ambito clinico che forense.
*Coordinatore DSM ASL Roma 2