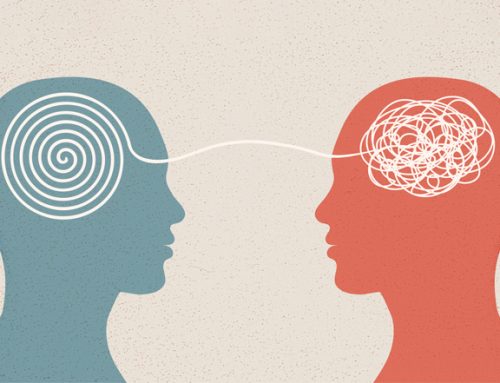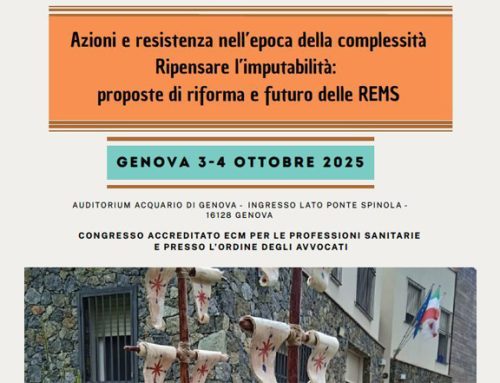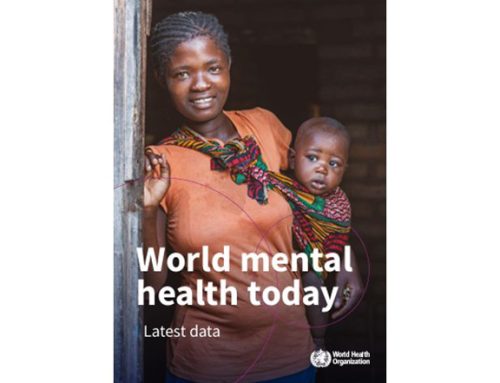A cura di Vittorio Di Michele1
Nell’attuale panorama della sanità italiana un argomento di acceso dibattito riguarda la drammatica limitazione di risorse utili a soddisfare pienamente e a garantire una assistenza di qualità alla platea maggiore possibile di cittadini nonché il ruolo del management per il governo della spesa e per la erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.
Spesa sanitaria e modelli gestionali delle aziende sanitarie
I modelli di management di riferimento applicati alle aziende sanitarie hanno goduto di una certa popolarità specialmente per il governo della spesa ospedaliera, per la quale siamo arrivati a livelli molto dettagliati e sofisticati di conoscenza. Per quanto attiene gli indicatori che vengono presi come riferimento e come proxy della qualità gestionale pur essendo apparentemente più semplici da misurare, per via dei consolidati percorsi produttivi ospedalieri chiari e misurabili e delle prestazioni sanitarie ivi prodotte, sono in realtà insoddisfacenti nel momento in cui si affronti la sanità territoriale o di comunità
In altre parole, ricercare una misura univoca semplice e facilmente enucleabile semplifica il bilancio econometrico, ma poco o nulla ci dice della pregnanza e della appropriatezza clinica, della qualità tecnica assistenziale o della qualità dei processi e degli esiti di salute a lungo termine collegati alla cronicità, che sono gli ambiti preferenziale della sanità distrettuale/territoriale inclusa la salute mentale territoriale. Nei servizi di salute mentale di comunità vengono erogati servizi alla persona intangibili, spesso a valenza sociosanitaria o addirittura squisitamente a valenza sociale, connotati da una forte valenza antropologica. Non di rado, infatti, interventi sanitari indirizzati alle persone che vivono in situazioni di marginalità o di abbandono, acquisiscono un loro senso etico sociale che trascende completamente dall’aspetto sanitario per diventare un incontro con l’altro in una prospettiva esistenziale di “prendersi cura” dell’altro, chiunque esso sia e di farlo per lunghi periodi di tempo, spesso per anni.
In questa cornice concettuale è evidente che talune scelte manageriali, sostenute invero dalla politica sanitaria di ultima generazione ovvero dalla riduzione delle Unità Operative in una sorta di pensiero unico, pur producendo degli efficientamenti di sistema non può mai coincidere con un aumento o un incremento qualitativo della qualità assistenziale richiesta in un contesto territoriale, dove i tempi della cura si dilatano e non coincidono con la semplice durata della degenza ospedaliera.
Fra l’altro la misura delle prestazioni ospedaliere non rende i sistemi più efficienti perché il tempo/uomo per unità di prestazione non si modifica. Anzi invariabilmente si allunga, perché aumenta il tempo burocratico di compilazione degli indicatori. Il tempo è incomprimibile e l’orario di lavoro non si può ampliare e quindi gli adempimenti utili alla “misurazione”, vengono sottratti al lavoro clinico.
Polemicamente mi permetto di stigmatizzare che la salute collettiva è spesso subordinata ad un artificio gestionale del conto economico aziendale in cui se non riesci a migliorare il numeratore, tagli il denominatore invocando l’efficienza e la sostenibilità del sistema!
Quali aspetti del lavoro territoriale possono essere valorizzati per la costruzione di una managerialità dedicata all’universo sanitario che è fuori dai muri dell’ospedale?
Management e servizi di salute mentale: il middle management.
Come è noto la rilevanza della spesa delle aziende sanitarie italiane dovrebbe riguardare il territorio per una percentuale del 55-60% della spesa di un’azienda sanitaria, un 40% a carico dell’ospedale e un 5% per la prevenzione. In realtà quindi il valore della produzione dovrebbe essere maggiore nel territorio che negli stabilimenti ospedalieri di una azienda sanitaria a fronte di investimenti nemmeno lontanamente comparabili. Speculativamente e ironicamente, direi che il vero modello Toyota Production System, ovvero il “fare di più con meno”, cioè l’utilizzare le (poche) risorse disponibili nel modo più produttivo possibile si applica da sempre nella salute mentale di comunità, dove l’attenzione all’utenza e alle concrete esigenze dello specifico territorio, è quotidiana e non eludibile. In queste realtà il paradigma manageriale viene sovvertito e si crea la necessità pragmatica di impostare una nuova cultura operativa che sia appropriata efficiente e “gradita” all’utenza.
Spesso ci si confronta con modelli gestionali che enfatizzano l’accorpamento di aziende e unità operative, le spending review, la digitalizzazione e la competizione fra ospedali invece di valorizzare la governance, intesa come sistematico approccio gestionale finalizzato a garantire elevati standard assistenziali e un miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati.
In altre parole, si valorizza la rigidità della corporate governance invece di promuovere la flessibilità della clinical governance, la quale è in grado di operare al livello di dettaglio in maniera più efficace e tempestiva.
Middle management e salute mentale di comunità
Nei servizi di salute mentale abbiamo a disposizione un management molto formato tecnicamente e molto solido sul piano manageriale, che svolge giornalmente le sue funzioni di raccordo fra la direzione strategica e l’area operativa con un approccio preferenzialmente di tipo funzionale collaborativo-trasversale e multiprofessionale.
D’altra parte, non sarebbe credibile svolgere delle attività cliniche, sociali e riabilitative di comunità e lavorare giornalmente sulla cronicità, senza l’autonomia individuale di tutti i componenti dell’equipe e senza un’attività che viene definita di supervisione, ma che in realtà è un audit bidirezionale o a direzione variabile. Per direzione variabile intendo che il case-manager di un determinato paziente, qualunque sia il suo ruolo riveste, di fatto, il ruolo di esperto dell’utente in oggetto. Questa modalità pervasiva di lavoro sfugge totalmente alle regole alle logiche e ai principi del management sanitario ospedaliero, ma nella realtà operativa è lo snodo principale dell’assistenza territoriale che opera in un contesto multiprofessionale e multiesperenziale.
Le figure professionali operanti nei servizi territoriali operano in autonomia focalizzandosi sui bisogni e sulle esigenze che nel corso del tempo possono venire a realizzarsi negli utenti in carico.
Ovviamente la grande limitazione di risorse obbliga a delle scelte e a delle selezioni di pazienti che massimizzino l’efficienza del team multiprofessionale e sortisca significativi benefici agli utenti, in una sorta di downgrading obbligato. In questo modello di lavoro informale, privo di riferimenti logico-organizzativi, diventano centrali la disponibilità al cambiamento, la possibilità di avere in loco (ovvero nel comune di residenza che può essere molto distante dal centro di salute mentale) le risorse umane, formali e informali utili ad una presa in carico della persona, le reti sociali degli stakeholder e dei familiari laddove presenti ed organizzate. Questa modalità di organizzazione del lavoro, come appare evidente, è piuttosto difficile da scomporre in elementi misurabili, ed è difficile da trasformare in indicatori di esito, ma opera sul livello del valore umano ed etico di un servizio, sulla dedizione del personale e sulla capacità di appeal da parte degli stakeholder, degli enti locali, dell’associazionismo e nella stima e la fiducia di cui gode il personale dei servizi territoriali.
Un altro esempio paradigmatico di efficacia del middle management territoriale riguarda le procedure di deimplementazione di metodologie e prassi inefficaci o dannose, obsolete o eccessivamente onerose. Questo approccio viene affrontato giornalmente nella salute mentale comunitaria e riguarda le pratiche riabilitative, diagnostiche, le terapie psicologiche e psicosociali, i trattamenti non farmacologici, le terapie con farmaci a lento rilascio (i cosiddetti LAI) o in pronto, che vengono abbandonate perché decisamente inutili.
Parimenti il conservare prassi vecchie e desuete, ma che funzionano ovvero rimodulare o aggiornare prassi e protocolli, è un’altra caratteristica distintiva delle peculiarità operative dei servizi territoriali assolutamente divergente dalle prassi ospedaliere.
Questi elementi cruciali così sommariamente richiamati, chiariscono la singolarità delle competenze manageriali richieste per tali servizi, nei quali il valore non può essere determinato con un indicatore numerico, ma attraverso molteplici “misurazioni” qualitative che tengono conto della capacità professionale, della qualità del servizio e dei programmi di cura, del coinvolgimento in ogni singolo atto del valora umano nella sua sfera umanistica, emotiva, empatica, etica nonché della buona reputazione dei servizi pubblici e degli esiti di cura.
Una recente ricerca voluta dalla FIASO (2018) dimostra come i principali problemi nel rapporto tra top management e middle management indichino con elevata frequenza la carenza di comunicazione e di conoscenza reciproca.
Prendendo ad esempio il carico burocratico dei servizi sanitari, è curioso rilevare che l’introduzione di qualunque misura di miglioramento qualitativo e quantitativo delle prestazioni necessiti fatalmente di un sistema di misura di indicatori più o meno bizzarri. I nuovi indicatori misurano l’efficienza gestionale della misura introdotta ed in maniera indiretta la qualità tecnica. Questo criterio di valutazione dei risultati in una ricerca sperimentale non sarebbe ammesso, ma lo si accetta per misurare le attività clinica. Si tratta di un paradosso che ritengo inaccettabile e decisamente sbagliato, perché poggia su premesse erronee, seppur molto popolari, specie nell’ambito della programmazione sanitaria.
Sembrerebbe che la paura di investire sia direttamente proporzionale alla necessità di misurare le performance.
Ben pochi si rendono conto della onerosità e della perdita di tempo richiesta per gli adempimenti burocratici dei diversi settori e servizi, ma soprattutto sfugge ai non addetti al lavoro clinico – diversamente da quanto accade ai middle managers – che un adempimento burocratico, finalizzato al conseguimento di obiettivi economici e di budget, si impone se il leader del team è un responsabile di tipo gestionale, deputato a mantenere il sistema efficiente, ma non efficace e di qualità.
Nei servizi territoriali le osservazioni appena citate sono particolarmente cogenti e spiegano il perché si necessiti di misure gestionali confezionate ad hoc e adattate ai differenti contesti sociali, demografici, culturali e socioeconomici italiani.
Per questo, il middle management dei servizi territoriali deve avere caratteristiche innovative e basate su modelli pragmatici, con un forte radicamento nella esperienza clinica e nella operatività del quotidiano.
Anche per questa figura una leadership scientificamente ben ferrata, autorevole e con una lunga esperienza sul campo, migliora la comunicazione con il top management e con il team del servizio, che è tipicamente multiprofessionale e che usualmente ha esperienze, orientamenti dottrinali e propensioni individuali di tipo culturale estremamente diversificati.
D’altra parte, l’autorevolezza clinica non si costruisce dall’oggi al domani, al contrario delle competenze manageriali che sono più semplici da apprendere e applicare.
In conclusione, si ritiene che il modello di middle management attualmente presente nei servizi territoriali della salute mentale, appare facilmente esportabile ai nuovi contesti territoriali che si stanno delineando e un apprendimento tra pari, potrebbe essere una via percorribile per una crescita dei contesti di cura extraospedaliera del prossimo futuro.
Bibliografia.
Il middle management nella sanità italiana. Stato dell’arte e prospettive gestionali. Risultati del Forum Management Sanità. Istituto di Tecnologie Biomediche del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Novembre 2018
Note
1) Dipartimento di Salute Mentale, ASL Pescara.