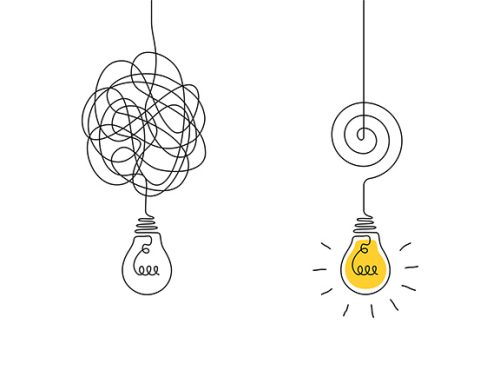di Pietro Pellegrini [1]
Da alcuni anni il prof. Paolo Cendon, con l’Associazione “Diritti in movimento”, sta promuovendo una proposta di modifica del codice civile, che insieme all’abrogazione dell’interdizione e inabilitazione e al contestuale rafforzamento dell’Amministrazione di sostegno, introduce il c.d. “patto di rifioritura”. A questo proposito prima di un commento dal punto di vista di uno psichiatra, conviene leggere la nuova formulazione proposta dell’art.411 c.c.
“Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre, a carico del beneficiario, determinate limitazioni o impedimenti alla possibilità di compiere atti di natura personale o patrimoniale, avuto riguardo all’esclusivo interesse del beneficiario medesimo. Dette limitazioni o impedienti dovranno avere carattere temporaneo salva possibilità di proroga motivata per il ricorrere di gravi motivi.
Nel caso di limitazione o impedimento ai sensi del precedente comma, il Giudice tutelare potrà, altresì, autorizzare il beneficiario al compimento dell’atto con l’assistenza dell’amministratore di sostegno.
In caso di dissenso tra amministratore di sostegno e beneficiario circa gli atti da compiere, il giudice tutelare – previa audizione del beneficiario, svolti i necessari accertamenti allorché sia emersa una insufficiente o inadeguata consapevolezza critica, presso quest’ultimo, intorno alla propria condizione patologica – assume con decreto motivato gli opportuni provvedimenti, compresa l’autorizzazione all’amministratore di sostegno a fare luogo comunque al compimento dell’atto, superando anche con mezzi coercitivi quel dissenso. Qualora si tratti di atti, accertamenti, terapie o interventi di natura o contenuto sanitario, il provvedimento del giudice dovrà conformarsi ai seguenti principi: a) verificare se il rifiuto, totale o parziale, o la revoca del consenso agli accertamenti diagnostici o ai trattamenti indicati per la patologia o a singoli passaggi del trattamento stesso, non risulti in concreto espressione di appropriate capacità e volontà, da parte del beneficiario, in ordine alla salvaguardia del proprio equilibrio esistenziale, dovendosi in tal caso riconoscere alle stesse attenzione e tutela prevalenti; b) riconoscere e rispettare in generale i bisogni, le aspirazioni e i valori del beneficiario; c) procedere solo quando l’assenza di un determinato intervento rischi di pregiudicare gravemente la salute dell’interessato e minacci contestualmente il benessere dei suoi familiari, della parte dell’unione civile o del convivente; d) evitare che risulti compromessa oltre il minimo necessario, nella forma e nella sostanza, la libertà personale del beneficiario; e) coinvolgere quest’ultimo, quanto più possibile, nella pianificazione e nell’aggiornamento dei piani terapeutici, trattamentali e di assistenza.”
Una prima impressione è che dietro affermazioni di grande buon senso, animate dalle migliori intenzioni, a mio parere si possano aprire rischi assai gravi di violazione dei diritti delle persone. Di buone intenzioni si sa son lastricate le vie dell’inferno.
Andiamo con ordine: il tema del consenso e dell’adesione alle cure esiste in ogni relazione comprese quelle di cura. Non vi sono dati certi ma solo in una minoranza dei casi si arriva ai trattamenti sanitari obbligatori (nel Dipartimento di Parma circa 1% dell’utenza della Salute mentale adulti). Si tratta di un problema reale per quanto difficile da definire sul piano quantitativo.
Nella presentazione della proposta di legge i limiti della180 anziché essere visti come punti di forza, specie se connessi e letti alla luce della legge 219/2017, vengono stigmatizzati in quanto ritenuti responsabili di un certo lassismo, di un “lassez faire” fino al disimpegno e all’abbandono visti come frutto esclusivo di pratiche non adeguate e non di carenze di risorse professionali e di strumenti e soprattutto di una perdita di diritti di cittadinanza. Nella psichiatria della “trattativa continua”, talora, interviene, in caso di reati, il procedimento penale, dolorosa e talora traumatica occasione per un esame di realtà e per un possibile percorso di cura. Un’evenienza apparentemente risolutiva ma spesso rischiosa visto il tasso dei suicidi e di incerta efficacia vista la percentuale di soggetti dipendenti da sostanze detenuti che pur potendo chiedere alternative di cura non vi accedono preferendo una pena di durata certa ad assai più faticosi trattamenti meno prevedibili nei tempi. Non solo ma le cure svolte in regimi di detenzione, una volta in libertà sono spesso seguite da brusche interruzioni e ricadute ma anche da percorsi ancora più devianti e talora persino criminali.
I profili di pericolo da rilevare in relazione alla proposta del Patto di rifioritura sono due: uno per la persona e l’altro per la concezione della cura e il sistema curante.
A) Persona
Pur in un contesto di beneficialità (sostanzialmente paternalisitico) in caso di dissenso fra amministratore di sostegno e beneficiario [2] si pongono anche in modo coercitivo limitazioni a carico della persona motivate da “insufficiente e inadeguata consapevolezza critica rispetto alla propria condizione patologica”.
La “Consapevolezza critica rispetto alla condizione patologica” è frutto di un lavoro terapeutico molto articolato e profondo e spesso all’inizio di una sintomatologia, di un disturbo prevale l’incertezza e la consapevolezza è solo parziale. Non solo ma anche sotto il profilo giuridico essa non è prevista dalla legge 219/2017 che limita gli interventi senza consenso come del resto la 180/1978 alle sole condizioni “urgenti”.
A carico della persona, il giudice ha la facoltà di disporre limitazioni temporanee ma prorogabili senza che sia indicato almeno nel testo di legge un termine massimo ed una procedura per la proroga come previsto ad es. dalla legge 180/1978. Anche la previsione dell’uso dei “mezzi coercitivi” è priva di indicazioni su quali siano, su chi, come, quando, dove, con quali garanzie e responsabilità, verranno applicati, visto che tra l’altro si incide sulla libertà (art 13 costituzione). Inoltre nulla si dice su come vengono gestiti eventuali rifiuti, opposizioni e violazioni potendosi realizzare un facile salto nel penale, vista la facilità con cui si può incorrere in certi reati, oltraggi a pubblico ufficiale e simili.
La situazione per gli atti, accertamenti, terapie o interventi di natura o contenuto sanitario, il provvedimento del giudice deve conformarsi a 4 principi di cui due sono inquietanti ed in contrasto con molte norme:
– punto a) se la persona non manifesta la capacità e la volontà di salvaguardare il proprio “equilibrio esistenziale” che tuttavia non viene definito;
– punto c) se l’assenza dell’intervento sanitario “rischi di pregiudicare gravemente la salute dell’interessato e minacci contestualmente il benessere dei suoi familiari, della parte dell’unione civile o del convivente”. In altre parole renda la persona pericoloso a sé e agli altri familiari.
Questione questa che con il codice Rosso (legge 69/2019) in caso di reati, assume rilevanza anche in ambito penale. Nella proposta Cendon ci si limita al “rischio” (termine molto generico, visto che vi sono molteplici fattori di rischio, predisponenti, precipitanti, statici, dinamici, di contesto).
La proposta sembra voler risolvere un problema, un conflitto per via giuridica, quando la strada da intraprendere dovrebbe essere un’altra, come per altro indicano con chiarezza i trattamenti degli adolescenti, che giuridicamente sono sottoposti alla responsabilità genitoriale e in certi casi anche del Tribunale per i Minori. Questi hanno tutte le prerogative che la legge intende introdurre ma esse risultano poco rilevanti ai fini della cura che si deve basare su consenso e partecipazione, su relazioni co-costruite su un incontro possibile.
Si introducono quindi condizioni quali “insufficiente e inadeguata consapevolezza critica rispetto alla propria condizione patologica”, “equilibrio esistenziale” e “rischi di pregiudicare gravemente la salute e minacciare contestualmente il benessere dei familiari” che non solo andrebbero definite in modo circostanziato, in riferimento anche alla loro determinazione, rilevabilità e modificabilità.
B) La concezione della cura e il Sistema curante
Come si impongono i trattamenti specie nel lungo termine? Come si superano le opposizioni, se non mediante modelli coercitivi? Il richiamo alla coazione benigna, rischia di essere solo una facciata che nasconde ben altre prassi di privazione della libertà e controllo che a loro volta si configurano come pericolose e non terapeutiche (basta guardare gli esiti, i tassi di suicidio nelle carceri). Lo stesso si potrebbe dire per pratiche educative coercitive e violente totalmente abbandonate, dopo Montessori, Dolci e Don Milani.
Quindi la domanda è se interventi realizzati con la coercizioni siano certamente efficaci e risolutivi?
La svolta verso la coercizione e la limitazione della libertà (certamente benigna nelle intenzioni ma anche nel processo reale e negli esiti?) dove si possono realizzare se non con una profonda modifica dell’assetto dei servizi, residenziali della salute mentale e delle dipendenze i cui responsabili dovrebbero assumersi il ruolo di controllori, non lasciando andare chi vuole allontanarsi. Era la linea di Muccioli….
Non si pensa di fare una cura nel territorio, in una casa, dalla quale si potrebbe fuggire, ma nella quale forse si può realizzare un programma dove rischi/benefici vengono valutati e condivisi.
Imporre trattamenti ha impatti sulle persone che vi sono sottoposte ma anche sul vissuto dei curanti, che ad un certo punto subiranno le decisioni del giudice e dell’amministratore di sostegno. Una condizione in sé antiterapeutica, perché la cura implica la libertà, perché non vi è riabilitazione senza la partecipazione attiva e motivata della persona.
Pensare che vi siano nell’ambito della salute mentale interventi brevi e risolutivi significa non conoscere la logica e l’evoluzione del trattamento di lungo termine che passa per sofferenze, incertezze, progressi, regressioni, rischi/benefici, passi in avanti, regressioni, possibili ricadute, specie nei disturbi che hanno andamento protratto, cronico e recidivante.
Il percorso di cura non è affatto lineare ma le violazioni e le rotture come parti essenziali della relazione terapeutica, la cui forza sta proprio in quell’alleanza che sa affrontarle, nel tempo che talora intreccia cura e vita. Questo non si realizza certo attraverso TSO territoriali ed un’estensione della posizione di garanzia a carico degli operatori.
Già ora si vedono gli effetti negativi di ordinanze del Giudici Tutelari sollecitate da Amministratori di sostegno contro la volontà del beneficiario che lo “obbligano” a restare in Comunità quando invece preferirebbe restare a casa. Cosa è meglio? Ma per la permanenza a casa occorrono presenze, culture, mezzi e impegno di tempo non necessari nella scelta residenziale pur più costosa e meno efficace e soddisfacente. Occorrerebbe risolvere i problemi dell’amministrazione di sostegno che se non esercitata da familiari vedono professionisti impegnati in modo assai variabile (da altissime disponibilità missionarie a interpretazione del compito come adempimento burocratico). Andrebbe riconosciuto il loro ruolo pubblico, riconoscere un’adeguata retribuzione e prevedere impegni precisi e al contempo un massimo di beneficiari. Questo può essere un tema del Recovery Plan.
La proposta di legge può essere uno stimolo al prendersi cura delle persone ma allora dobbiamo capire in quale modo? La logica in sanità deve essere quella della prevenzione, dell’accoglienza, dell’ascolto e dei diritti esigibili. Si può aumentare l’adesione alle cure sia con tecniche specifiche (intervenendo nell’infanzia) sia rispondendo ai bisogni sociali primari delle persone, alle loro aspettative, rispettandole e valorizzando il loro punto di vista.
Il problema del consenso e dell’adesione alle cure è in primis sociosanitario, con aspetti clinici ed è solo residualmente giuridico. In questo ambito si sono previste forme di rifiuto (legge 219/2017). Ora anziché prevedere forme coercitive sarebbe utile proporre norme per aumentare diritti, tutele e garanzie, le forme di mediazione e conciliazione.
Le persone hanno bisogno di chi si prende cura di loro, di amministratori di sostegno disponibili e se non familiari adeguatamente retribuiti, periti di parte, difensore civico, ruolo di terzi, associazioni di utenti e di familiari.
Si debbono prevedere investimenti in personale, nuovi strumenti come il Budget di salute, le nuove tecnologie, e diversi modelli assistenziali incentrati sulla propria abitazione in ogni fase della vita della persone nel mondo reale, secondo i ritmi della natura in aperta campagna (dove oltre alla rifioritura, c’è il raccolto ma anche la caduta delle foglie) e non spingere seppure a fin di bene, all’approvazione di norme apparentemente salvifiche, che semplificando la complessità della relazione terapeutica potrebbero portare a soluzioni istituzionali e coercitive, ad una rifioritura per piante in serra?
Note
[1] Direttore Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale Dipendenze Patologiche, Ausl di Parma
[2] In caso di dissenso tra amministratore di sostegno e beneficiario, medico-paziente, il riferimento è il Giudice Tutelare. Viene da chiedersi se non sarebbe meglio prevedere Strumenti di mediazione e conciliazione. Questo potrebbe essere la risposta anche ai conflitti intrafamiliari, tra genitori e figli, coniugi, conviventi ecc.