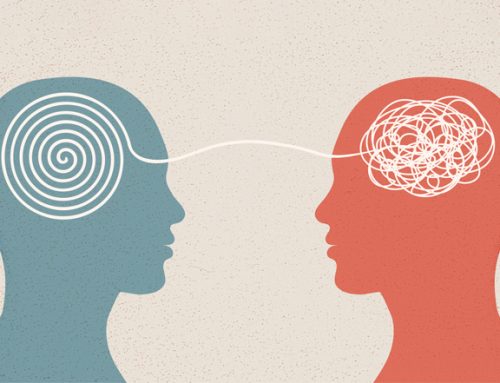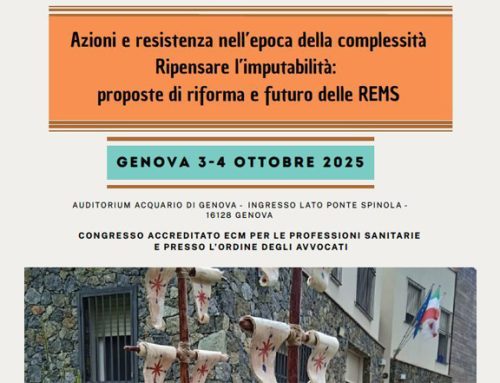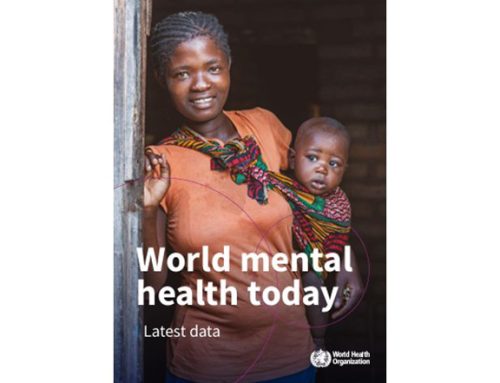Nel settore della Psichiatria di Comunità vige oggi una certa confusione su come trasferire nella pratica una serie di indicazioni teoriche per dare un senso tecnico al lavoro quotidiano. Nella dicotomia tra i trattamenti psicosociali evidence-based (EB), che richiedono formazione rigorosa, sistematicità, intensità, supervisione costante, valutazione degli outcome e confronto con la fidelity, e la pratica as usual, in cui il termine “usual” ha assunto il significato di “general”, generico, approssimativo, afinalistico, basato sul caso, non misurabile e non necessitante di formazione continua, alla fine nei servizi si rischia di non implementare i primi, perché troppo dispendiosi di tempo e di risorse, né di conferire alla seconda la dignità di una tecnica, seppure non esattamente rispondente alle linee guida o alle raccomandazioni scaturite dalle ricerche. Ne consegue che, nella maggioranza dei casi, la presa in carico dei pazienti non è in realtà una presa in cura, ma rischia di essere una sine cura, e che la psichiatria di comunità, invece che assumere le caratteristiche di un approccio biopsicosociale, misurabile e riproducibile, si identifica prevalentemente con una modalità relazionale, per la quale possono bastare solo una buona dose di umanità, un buon carattere e una generica disponibilità.
Il testo “Pratiche basate sull’evidenza e pratiche promettenti nella psichiatria di comunità. Orientare metodologicamente il lavoro quotidiano dei professionisti” vuole colmare il gap esistente tra l’implementazione dei trattamenti EB, che non può riguardare tutti i pazienti che ne avrebbero bisogno, e l’aspecificità, a volte iatrogena, della routine quotidiana. In altre parole, si vuole attribuire un valore tecnico a pratiche non sempre suffragate dall’evidenza, adottate dalla maggioranza degli operatori, spesso apprezzate molto da utenti e familiari, ma che sono dovute, prevalentemente, o alla motivazione/impegno particolari di alcuni “eroici” professionisti o alle loro peculiarità caratteriali e “modi di essere”. Per questo, la loro applicazione dipende prevalentemente da fattori soggettivi e arbitrari, la cui assenza ne compromette l’offerta. A ben riflettere, una tale “precarietà” dell’offerta di cura non sarebbe giustificata in nessuna branca della medicina.
L’obiettivo, quindi, è quello di offrire al personale dei servizi una guida pratica, più commisurata al loro background culturale e professionale (si vedano gli infermieri che provengono dai reparti ospedalieri o gli OSS) di quanto non lo siano i trattamenti psicosociali EB, così come richiesto dai manuali proceduralizzati, sistematizzando in modo più metodologico le mille azioni che gli operatori compiono quotidianamente con i loro pazienti e con i rispettivi familiari, in modo che anche chi non ha una precedente formazione psicosociale e/o psicoterapica possa orientare la relazione con il paziente ad un esito e non ad un generico “stare assieme”.
Il libro si compone di sei parti. Nella Parte I vengono discusse le problematiche relative all’adozione di un approccio EBM nella psichiatria di comunità; nella Parte II sono descritte le buone pratiche comunitarie; la Parte III tratta le attività basiche di ogni processo terapeutico e riabilitativo; la Parte IV prende in esame le strategie psicosociali EB, derivate dai rispettivi trattamenti proceduralizzati; la Parte V è dedicata alla pratiche alla ricerca di evidenza (pratiche promettenti) e, infine, nella Parte VI si illustra la proposta di un modello organizzativo interdisciplinare/interservizi centrato sulla persona.